DIRITTO E VERITÀ
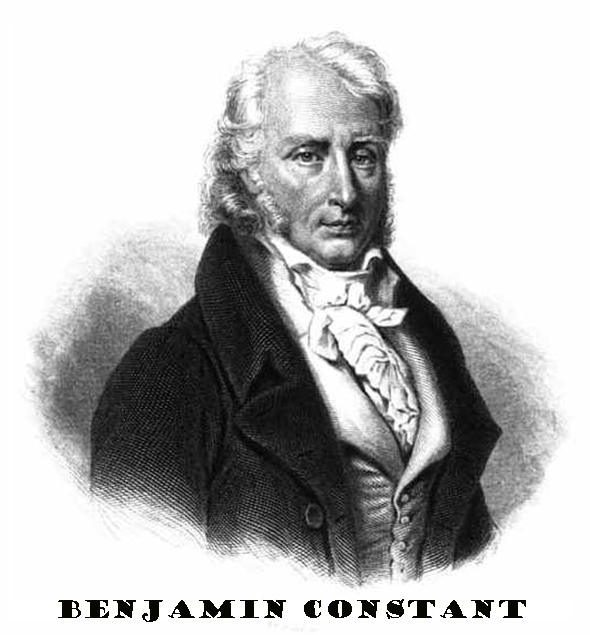
Quanto segue è uno scritto di Henri-Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830), filosofo e politico di orientamento liberale, noto per la sua controversia con Kant. Il testo - tratto da “Des Réactions politiques”, cap. VIII, “Des principes” - redatto nel gennaio-febbraio del 1796 e pubblicato poco dopo, ha avuto anche una traduzione e un’edizione tedesca nella rivista “Frankreich im Jahr 1797”, pubblicata da K. F. Cramer. Kant ne prenderà conoscenza grazie a tale rivista (cfr. Kurt Kloocke, “Benjamin Constant, une biographie intellectuelle, Droz, Genève 1984, p. 80).
In Constant è possibile intravedere un precursore del diritto di “epicheia” (concetto cristiano molto occultato dalle confessioni religiose in quanto consistente nel disobbedire a leggi ritenute ingiuste), proprio là, dove tratta del dovere della verità.
Negli uomini di sinistra, di destra, di centro ed, in modo addirittura gaudente, negli uomini confessionali, quindi negli statalisti, nel legulei, e nei giustizialisti, ecc., vi è una sorta di malattia mentale, che fa apparire queste persone “sinistre”, ma sarebbe meglio dire sinistrati pensatori, nella misura in cui si ostinano a ragionare pigramente solo in superficie, senza mai verificare i pregiudizi, consistenti in “imperativi categorici”, che costituiscono i fondamenti della maggior parte delle loro argomentazioni.
Questa loro mancanza di pensiero comporta il declino della politica, la quale diventa perciò “o-scena” in quanto fuori dalla scenadell’attualità e quindi anacronistica.
Alla seguente pagina di Benjamin Constant, testimone del fatto che tale declino ha le sue radici nelle primigenie controversie sulla questione del dovere della verità, a loro volta espressioni delle radici essenziali della corruzione ma anche del suo futuro superamento mediante il diritto di epicheia, filosoficamente consistente nella categoria scientifico-spirituale dell’individualismo etico che promuoverà poi Rudolf Steiner nella sua “Filosofia della libertà”, ho fatto seguire un capitolo del libro di Carlo Lottieri (vivente) “Credere nello Stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il bello a Wikileaks”, (Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 2011) che reputo necessari per comprendere come sia difficile oggi incarnare la triade illuminista “liberté, égalité, fraternité” senza una reale filosofia della libertà, base della triarticolazione sociale, di cui Steiner parlava. Il titolo del capitolo: “L'illuminismo: una verità disincarnata” (Lottieri, op. cit. p. 121).
Benjamin Constant
Non tutti hanno diritto alla verità
- a cura di Nereo Villa -
Si è tanto e così sciaguratamente abusato della parola PRINCÌPI [il maiuscolo è mio - ndc] che chi reclama per essi rispetto e obbedienza è considerato di solito un astratto sognatore, un chimerico ragionatore. Tutte le fazioni hanno in odio i princìpi: gli uni li considerano responsabili dei mali passati, gli altri vi scorgono dei moltiplicatori delle difficoltà presenti. Coloro che non riescono a ricostruire ciò che non è più, se la prendono con i princìpi del sovvertimento; coloro che non sanno far funzionare l’esistente, li accusano della propria impotenza; e la stessa massa che, nel suo essere un che di composito, non avendo alcun interesse nelle eccezioni individuali, ne ha uno assai urgente a che i princìpi generali siano osservati, vedendoli oggetto di volta in volta delle dichiarazioni di tutti i partiti, si mostra prevenuta nei loro confronti e si accende di passione contro una cosa della quale da tutti sente dir male, mentre questa cosa è la sola capace di garantirla contro tutti costoro.
La riabilitazione dei princìpi costituirà un’impresa al tempo stesso utile e soddisfacente: dedicandocisi, si potrà uscire dalla sfera di circostanze nella quale ci si trova incessantemente a mal partito in una infinità di modi. Si sfuggirà a ogni riferimento personale agli individui: anziché dover rilevare imprudenze o debolezze, si dovrà aver a che fare con il solo pensare. Al vantaggio di approfondire meglio le opinioni, si unirà quello, non meno prezioso, di dimenticare gli uomini (denunciare i princìpi in generale non è rischiare alla fine di affondare sistematicamente nell’arbitrarietà? E d’altra parte, esagerare il valore dei princìpi non porta a una conseguenza identica?).
Questo lavoro, tuttavia, esigerebbe sviluppi non consentiti dai limiti di un’opera che mi affretto a pubblicare nella speranza, forse mal riposta, di una sua utilità. In seguito, forse, se qualche altro più abile scrittore non riuscirà a superarmi in questo percorso, cercherò di esporre quelli che a mio giudizio sono i princìpi elementari della libertà. Oggi come oggi non posso che indicare le idee fondamentali di un sistema che consta di una lunga catena di ragionamenti, e sono obbligato ad affidarmi al lettore affinché supplisca ai ragionamenti intermedi, qualora sia sufficientemente interessato a farlo.
Un principio è il risultato generale di un certo numero di fatti particolari. Ogni volta che l’insieme di questi fatti conosce qualche cambiamento, il principio che ne risulta si modifica: ma allora questo mutamento diventa esso stesso un principio.
Tutto nell’universo ha dunque i suoi princìpi, vale a dire che tutte le combinazioni, vuoi di esistenze vuoi di avvenimenti, conducono a un risultato: e tale risultato è sempre uguale, ogni volta che le combinazioni sono le stesse. Questo risultato è ciò che chiamiamo principio.
Questo risultato non è generale se non in rapporto alle combinazioni dalle quali scaturisce. Esso è dunque generale solo in modo relativo e non assoluto. Tale distinzione è di grande importanza, ed è per la sua mancata formulazione che si sono concepite tante idee erronee su ciò che costituisce un principio.
Si danno dei princìpi universali, perché vi sono dei dati primi che ricorrono egualmente in tutte le combinazioni. Ma ciò non significa che a questi princìpi fondamentali non occorra aggiungere altri princìpi, risultanti da ciascuna combinazione particolare.
Quando si dice che i princìpi generali sono inapplicabili alle circostanze, si dice semplicemente che non si è scoperto il principio intermedio che la combinazione particolare di cui ci si occupa esige. Ciò significa aver perduto uno degli anelli della catena; però questo non implica affatto che la catena per ciò stesso non esista (ciò che qui è in gioco, su uno sfondo politico, è l’opposizione fra la teoria e la pratica giudicata da taluni insormontabile. I fautori di una limitazione dei princìpi vogliono far posto all’arbitrarietà, all’opportunismo col pretesto che “assiomi, metafisicamente veri, politicamente possono essere falsi”; “Réactions politiques”, Ed. a cura di Philippe Raynaud, Flammarion, Paris 1988, IX, p. 142; la prova dell’esperienza essendo qui considerata fatale alla teoria. Chi sono i detrattori dei princìpi se non quelli stessi che rimettono in discussione la Rivoluzione francese a motivo del Terrore? Sono quelli che reclamano il ritorno della monarchia, il ritorno di una politica concreta e notoria, della cui validità la storia ha fornito le prove, piuttosto che una politica razionale impossibile nella pratica. Contro costoro, Constant intende riabilitare la FILOSOFIA DEL GIUSTO MEZZO esponendo una dottrina dei princìpi intermedi e riaffermando per mezzo di questa il legame indefettibile fra la teoria e la pratica. I princìpi non sono delle astrazioni ed è precisamente l’esperienza che potrebbe darne la prova, a condizione di non ignorare i princìpi intermedi).
I princìpi secondari sono altrettanto immutabili dei princìpi primi. Ciascuna interruzione della grande catena non può esser colmata che con un solo anello.
Se attualmente noi disperiamo spesso dei princìpi, è per il fatto che non li conosciamo tutti. Quando si dice che sussiste la tale circostanza che costringe a deviare dai princìpi, non ci si capisce. Ogni circostanza invoca solamente il principio che le è proprio, poiché l’essenza di un principio non sta nell’essere generale, o applicabile a molti casi, ma nell’essere fisso; e questa qualità costituisce così bene la sua essenza, che tutta la sua utilità risiede precisamente in essa.
I princìpi non sono dunque vane teorie, destinate unicamente ad essere dibattute negli oscuri ridotti delle scuole. Sono verità fra loro coerenti, capaci di spingersi gradualmente sino alle applicazioni più circostanziate, e di coinvolgere i minimi particolari della vita sociale, se solo sapessimo seguire il loro concatenarsi.
Allorché, nel bel mezzo di una associazione di uomini, viene introdotto d’improvviso un principio primo, separato da tutti i princìpi intermedi che lo fanno discendere sino a noi e lo adattano alla nostra situazione, non c’è dubbio che si produca un grande disordine: poiché il principio strappato da tutto quanto gli sta attorno, spogliato di tutti i suoi sostegni, circondato da cose che gli sono contrarie, non è che distruzione e sconvolgimento (nel capitolo VII delle “Réactions politiques”, op cit., p. 129, Constant già scriveva: “Tutto quello che ho voluto provare è che l’esagerazione dei princìpi, essendo il mezzo più infallibile per renderli inapplicabili, sarà sempre una delle armi più pericolose che possano impiegare i fautori dei pregiudizi”); ma non è colpa del principio primo adottato, è colpa dei princìpi intermedi che sono sconosciuti; a precipitare tutto nel caos, non è l’adozione del primo, ma l’ignoranza di questi ultimi.
Applichiamo queste idee ai fatti e alle istituzioni della politica, e ci avvedremo del perché sino ad oggi i princìpi siano stati denigrati da uomini avveduti, e considerati da uomini semplici alla stregua di cose astratte e inutili. Ci avvedremo parimenti del perché I PREGIUDIZI, POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE AI PRINCÌPI, HANNO FINITO COL GODERE DEL FAVORE CHE SI RIFIUTAVA AI PRIMI.
Naturalmente, essendo i princìpi nient’altro che il risultato dei fatti particolari, ne consegue che, nell’associazione politica, essendo questa il risultato degli interessi di ciascuno, o, per dirla in poche parole, costituendo l’interesse comune di tutti, i detti princìpi avrebbero dovuto esser cari a tutti e a ciascuno; ma, in forza delle istituzioni che vigevano e che erano il risultato dell’interesse di alcuni di contro al comune interesse di tutti, era inevitabile dovesse accadere quanto si è appena detto. Non fu possibile promuovere dei princìpi se non isolatamente, lasciando al caso il compito di guidarli e rimettendo ad esso il bene o il male che dovevano produrre; ne doveva seguire quel che in effetti ne è seguito, che cioè, essendo il primo effetto dei princìpi distruttivo, un’idea di distruzione è rimasta ad essi legata.
I PREGIUDIZI, INVECE, HANNO GODUTO DEL GRANDE VANTAGGIO CHE, ESSENDO LA BASE DELLE ISTITUZIONI, SI SONO ADEGUATI ALLA VITA COMUNE GRAZIE ALLA CONSUETUDINE CON CUI VI SI FA RICORSO: HANNO AVVILUPPATO STRETTAMENTE TUTTI GLI ASPETTI DELLA NOSTRA ESISTENZA; SONO DIVENUTI QUALCOSA DI INTIMO; HANNO PERVASO TUTTI I NOSTRI RAPPORTI; E LA NATURA UMANA, CHE SEMPRE SI ADATTA A CIÒ CHE ESISTE, HA FATTO DEI PREGIUDIZI UNA SPECIE DI RIPARO, UNA SORTA DI EDIFICIO SOCIALE, PIÙ O MENO IMPERFETTO, MA QUANTO MENO CAPACE DI OFFRIRE UN ASILO. OGNI UOMO, RISALENDO IN QUESTO MODO DAI SUOI INTERESSI INDIVIDUALI AI PREGIUDIZI GENERALI, SI È LEGATO A QUESTI ULTIMI SCORGENDOVI DEGLI STRUMENTI ATTI A CONSERVARE I PRIMI (Che cosa sono in realtà QUESTI PREGIUDIZI di cui parla Constant? Ciò che costituisce la forza dei pregiudizi è il loro carattere “intimo” secondo il termine usato dall’autore, è la familiarità che essi hanno con noi. Essi SONO SINONIMI DI TRADIZIONE, pongono la NECESSITÀ CHE TUTTO DEBBA ACCADERE SEMPRE COME È ACCADUTO; permettono di accostare il reale con l’ausilio dell’esperienza passata - in tutto quello che essa contiene di arbitrario -, esperienza alla quale ogni cosa, in definitiva, deve conformarsi. ALLORA nulla più è sconosciuto, incerto, ed È LA SICUREZZA E LA CERTEZZA DELL’APPLICABILITÀ DEI PREGIUDIZI A COSTITUIRNE LA FORZA).
I princìpi, seguendo un cammino precisamente opposto, hanno conosciuto una sorte del tutto diversa. I princìpi generali si sono delineati per primi, non in ragione diretta dei nostri interessi, e in opposizione ai pregiudizi che proteggevano questi interessi (effettivamente, i princìpi non mirano all’interesse particolare ma a un interesse universale). Hanno assunto in tal modo il duplice carattere di estranei e di nemici. Si è visto in essi qualcosa di generale e di distruttivo, mentre i pregiudizi sono apparsi come cose individuali e preservatrici.
QUANDO DISPORREMO DI ISTITUZIONI FONDATE SUI PRINCÌPI, L’IDEA DI DISTRUZIONE FINIRÀ CON L’APPLICARSI AI PREGIUDIZI, PERCHÉ ALLORA SARANNO QUESTI ULTIMI AD ESSERE LESIVI.
La dottrina dell’eredità, per esempio, è un pregiudizio astratto, tanto astratto quanto lo può essere la dottrina dell’uguaglianza. Ma l’eredità, di cui era stato necessario organizzare l’esistenza per il solo fatto che esisteva, dipendeva da un concatenarsi di istituzioni, di abitudini, di interessi che si spingeva sino all’individualità più intima di ciascun uomo. L’uguaglianza, all’opposto, per il solo fatto di non essere riconosciuta, non dipendeva da nulla, dava addosso a ogni cosa, e non toccava gli individui se non per sconvolgere il loro modo d’essere. Nulla di più ovvio, dopo l’esperienza dello sconvolgimento, che l’ODIO PER IL PRINCIPIO e l’AMORE PER IL PREGIUDIZIO.
Ma rovesciate questa situazione di cose: immaginate la dottrina dell’uguaglianza riconosciuta, organizzata, e formante il primo anello della catena sociale, mescolata di conseguenza a tutti gli interessi, a tutti i calcoli, a tutti gli accomodamenti della vita privata o pubblica. Supponete ora la dottrina dell’eredità scagliata isolatamente, e come teoria generale, contro questo sistema: a distruggere sarà allora il pregiudizio; a preservare, il principio.
Mi si permetta ancora un esempio. È un principio universale, vero allo stesso modo in tutti i tempi e in tutte le circostanze, che NESSUN UOMO PUÒ ESSER OBBLIGATO SE NON DALLE LEGGI ALLA CUI FORMAZIONE ABBIA CONTRIBUITO. In una società molto ristretta, questo principio può avere applicazione immediata, e non necessita, per entrare nell’uso, di un principio intermedio. Ma in una situazione diversa, in una società molto numerosa, occorre aggiungere un nuovo principio, un principio intermedio a quello testé citato. Questo principio intermedio è che gli individui possono contribuire alla formazione delle leggi, sia in prima persona, sia per mezzo di loro rappresentanti. Chi volesse applicare il primo principio a una società numerosa, senza far valere il principio intermedio, la sconvolgerebbe inevitabilmente: ma questo sconvolgimento, che dimostrerebbe l’ignoranza o l’imperizia del legislatore, nulla proverebbe contro il principio. A far vacillare lo Stato non sarebbe l’aver riconosciuto che ciascuno dei suoi membri deve concorrere alla formazione delle leggi, ma l’aver ignorato che, di là da un dato numero, per concorrervi doveva farsi rappresentare (François Boituzat scrive giustamente a questo riguardo: “Nella sua difesa dei princìpi, Constant si rifà all’articolo 6 della “Dichiarazione lei diritti dell’uomo e del cittadino”, il quale, recitando che “la legge è l’espressione della volontà generale”, sottolinea che “tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o attraverso i loro rappresentanti alla sua formazione”. Disgiungendo il principio rousseauiano della sovranità inalienabile dalla dottrina dei diritti dell’uomo, egli afferma, per salvare quest’ultima, che un tale principio non potrebbe reggere se posto “isolatamente e in modo assoluto”, poiché chiunque volesse applicarlo a una società molto popolosa “senza impiegare l’intermediario la sconvolgerebbe infallibilmente”; cf. “Un droit de mentir? Constant ou Kant”, PUF, Paris 1993, pp. 16-17).
La morale è una scienza molto più approfondita della politica, perché, essendo il bisogno di morale qualcosa che va oltre la quotidianità, lo spirito degli uomini ha dovuto consacrarvisi maggiormente, e la sua direzione non è stata falsata dagli interessi personali dei detentori o degli usurpatori del potere. Essendo inoltre meglio conosciuti i princìpi intermedi della morale [ciò che Constant chiama “princìpi intermedi” non è altro che la necessaria aggiunta di pensare occorrente al pensiero astratto affinché non cada nell’anacronismo ma sia costantemente vivente nel presente - ndc], i suoi princìpi astratti non sono screditati: la catena è costruita in modo migliore, e nessun principio primo ne discende con l’ostilità e il carattere devastante che l’isolamento conferisce alle idee così come agli uomini.
E tuttavia è fuor di dubbio che i princìpi astratti della morale, separati dai loro princìpi intermedi, produrrebbero nelle relazioni sociali degli uomini un disordine pari a quello che i princìpi astratti della politica, separati dai loro princìpi intermedi, necessariamente producono nelle loro relazioni civili.
Per esempio, il principio morale che è un dovere dire la verità, inteso incondizionatamente e senza distinzione, renderebbe impossibile qualsiasi società (si può egualmente pensare che rinunciare al dovere della veridicità porterebbe alla distruzione stessa della società, perché il rigetto di questo dovere scalzerebbe ogni fiducia tra gli uomini e ogni legame sociale. La società è figlia di un antico contratto tra gli individui: ora, se la parola non ha più valore, non lo ha neppure questo contratto, né gli obblighi e gli impegni che esso impone. Tuttavia, se il dovere di veridicità è un principio giusto, può rivelarsi distruttivo non appena sia eretto a principio incondizionato. Constant si accinge pertanto a proporre un dovere di veridicità sub condicione). NE ABBIAMO LA PROVA NELLE DIRETTE CONSEGUENZE CHE UN FILOSOFO TEDESCO (il fatto che Constant non nomini Kant direttamente è segno di disprezzo o di rispetto per un filosofo al quale non si desidera associare quel che a proprio giudizio è un errore di analisi?) HA TRATTO DA QUESTO PRINCIPIO, ARRIVANDO AD AFFERMARE CHE MENTIRE A DEGLI ASSASSINI CHE CI DOMANDASSERO SE UN NOSTRO AMICO CHE STANNO INSEGUENDO È RIFUGIATO IN CASA NOSTRA, SAREBBE UN CRIMINE (nel 1795, Kant ha pubblicato il suo “Per la pace perpetua”. Vi si può leggere: “Per quanto la massima ‘L’onestà è la miglior politica’ implichi una teoria, che la pratica purtroppo assai spesso smentisce, tuttavia la massima parimenti teoretica ‘L’onestà è migliore di ogni politica’ è al di sopra di ogni obiezione, è anzi la condizione indispensabile della politica” (Appendice I, “Sulla discordanza tra morale e politica in ordine alla pace perpetua”). Constant non ignora né la “Fondazione della metafisica dei costumi” né questo testo allorché scrive “Delle reazioni politiche”. Coniuga quindi gli scritti kantiani e la propria esperienza per produrre questo caso di casuistica. L’esempio qui proposto troverà un’eco in un testo posteriore di Kant (cf. “Essere sinceri è anche un dovere verso se stessi”; Cfr. Immanuel Kant Benjamin Constant, “È lecito mentire”, Milano, 2009 p. 47), che dunque Constant non poteva conoscere quando redigeva il testo delle “Reazioni politiche”. Noi sappiamo, segnatamente grazie alle prospettive del “Cours de politique constitutionne” di Constant, quale fosse allora la situazione in Francia e come questa situazione abbia potuto nutrire la sua riflessione. LA POLIZIA INCORAGGIAVA LA DELAZIONE (DI NOTTE SI SFONDAVANO LE PORTE DELLE ABITAZIONI), LA PENA DI MORTE ERA RICHIESTA CONTRO CHIUNQUE DESSE ASILO A RICERCATI; cfr. “Fragments d’un ouvrage abandonné…”, BNF, Naf. 14363, foglietto 105a; “UNA DONNA CONOSCIUTA PER LA SUA GENEROSITÀ AVEVA DATO ASILO A UN FUGGIASCO; LO SVENTURATO LA DENUNZIÒ; COSTUI EBBE LA GRAZIA: LEI FU BRUCIATA VIVA”; “Des suites de la contre-révolution en Angleterre…”, 1799, p. 74; scriveva Constant a proposito dell’Inghilterra del XVII secolo, ma puntando il dito contro la Repubblica francese... “MI SONO DOMANDATO A VOLTE CHE COSA FAREI SE MI TROVASSI RINCHIUSO IN UNA CITTÀ DOVE FOSSE VIETATO, PENA LA MORTE, DARE ASILO A CITTADINI ACCUSATI DI CRIMINI POLITICI”; “Cours le politique constitutionne”, 1872, volume I, p. 248; precisamente alla luce di queste circostanze e delle coeve riflessioni di Constant è da considerarsi la controversia con Kant).
Se questo principio primo ha potuto essere accolto senza difficoltà, lo si deve unicamente ai princìpi intermedi.
Ma, mi si dirà, come scoprire i princìpi intermedi che mancano? Come arrivare quanto meno a sospettarne l’esistenza? Quali segni sussistono che esista l’ignoto?
Ogni volta che un principio, dimostratosi vero, sembra inapplicabile, è perché noi ignoriamo il principio intermedio che contiene la modalità d’applicazione.
Per scoprire quest’ultimo principio, occorre definire il primo. Nel definirlo, nel considerarlo in tutti i suoi rapporti, percorrendone l’intera circonferenza, troveremo il legame che lo unisce a un altro principio. In questo legame è, di solito, la modalità d’applicazione. Se non la si trova, occorre definire il nuovo principio al quale saremo stati condotti. Esso ci porterà verso un terzo principio, ed è fuor di dubbio che seguendo la catena perverremo alla modalità d’applicazione.
Prendo come esempio il principio morale che ho appena citato, che dire la verità è un dovere.
Questo principio, preso così com’è, è inapplicabile. Distruggerebbe la società. Ma, se lo rigettate, la società non ne sarà meno distrutta, giacché le basi della morale saranno sovvertite (di conseguenza, l’onestà diventa un valore relativo, sospeso, dipendente dalla situazione, non è più dunque un dovere assoluto; e proprio su questo insiste d’ora in poi il testo).
Occorre dunque cercare la modalità d’applicazione, e a questo scopo occorre, come abbiamo appena detto, definire il principio.
Dire la verità è un dovere. Che cos’è un dovere? IL CONCETTO DI DOVERE È INSEPARABILE DA QUELLO DI DIRITTO: UN DOVERE È CIÒ CHE, IN UNA PERSONA, CORRISPONDE AI DIRITTI DI UN’ALTRA PERSONA. LÀ DOVE NON VI È ALCUN DIRITTO, NON SI DÀ ALCUN DOVERE.
DIRE LA VERITÀ NON È DUNQUE UN DOVERE SE NON VERSO COLORO CHE HANNO DIRITTO ALLA VERITÀ (certamente, ma chi sarà a designare gli aventi diritto alla verità? Chi può affermare legittimamente che il tale ha diritto alla verità e che il tal’altro non può pretenderlo? Constant non lo dice, e possiamo soltanto supporlo; cfr. la nota successiva). MA NESSUN UOMO HA DIRITTO A UNA VERITÀ CHE SIA DI NOCUMENTO AD ALTRI (il limite del dovere è nel caso in questione il diritto. Così, se il mio dovere è di essere sincero, di dire la verità, ciò non è che in rapporto a un diritto. È sufficiente dunque che un individuo non abbia diritto alla verità perché cessi il dovere di veridicità nei suoi confronti e diventi legittimo il fatto di mentirgli. Nel caso posto da Constant, si può supporre che questi assassini molto semplicemente non hanno diritto alla verità perché essi non si pongono alcun dovere, in ogni caso non quello del rispetto della vita altrui. Non si può concedere un diritto all’assenza di un dovere senza correre il rischio dell’arbitrarietà. Di più, quel che qui è egualmente in gioco è un conflitto tra due doveri che si pretendono assoluti: il dovere della veridicità e quello di proteggere la vita altrui. Constant si rifiuta di fare del dovere di essere veridici un imperativo assoluto, perché si rifiuta di screditare il dovere di proteggere la vita altrui).
Ecco, così mi sembra, il principio divenuto applicabile. Definendolo, abbiamo scoperto il legame che lo univa a un altro principio, e la ricongiunzione di questi due princìpi ci ha fornito la soluzione della difficoltà che ci bloccava (così, come mostra Constant, se i princìpi sono troppo rigidi, finiranno con l’essere, in mancanza di possibili sfumature, rigettati dagli uomini, anche da quelli di buona volontà).
Osservate la differenza tra questo modo di procedere e quello di rigettare il principio. Nell’esempio che abbiamo scelto, l’uomo colpito dagli inconvenienti del principio che sostiene che dire la verità è un dovere, anziché definirlo e cercarne la modalità d’applicazione, si sarebbe accontentato di inveire contro le astrazioni, dicendo che non sono fatte per il mondo reale, e avrebbe ridotto tutto alla dimensione dell’arbitrarietà. Avrebbe inferto all’intero sistema della morale un tale scossone che ne avrebbero risentito tutte le sue articolazioni. Al contrario, definendo il principio, scoprendo il rapporto che lo lega a un altro principio, e in questo rapporto la modalità d’applicazione, abbiamo trovato l’esatta modificazione del principio della verità, che esclude qualsiasi arbitrarietà e incertezza.
Il fatto che ogni principio racchiuda, sia in se stesso, sia nel suo rapporto con un altro principio, la sua modalità di applicazione, è un’idea probabilmente nuova, ma, mi sembra, di notevolissima importanza.
UN PRINCIPIO, RICONOSCIUTO COME VERO NON DEVE DUNQUE MAI ESSERE ABBANDONATO, ANCHE SE DOVESSE PARERE PERICOLOSO. Deve essere descritto, definito, combinato con tutti i princìpi circonvicini, sin che non si sia trovato il modo di por rimedio ai suoi inconvenienti, e di applicarlo come va applicato.
La dottrina opposta è assurda nella sua essenza e disastrosa nei suoi effetti.
È assurda perché prova troppo e provando troppo si distrugge da sé. DIRE CHE I PRINCÌPI ASTRATTI NON SONO CHE TEORIE VANE E INAPPLICABILI, SIGNIFICA ENUNCIARE A PROPRIA VOLTA UN PRINCIPIO ASTRATTO. Perché questa opinione non è un fatto particolare, ma un risultato generale. Significa dunque enunciare un principio astratto contro i princìpi astratti e, per ciò stesso, tacciare di nullità il proprio principio. È CADERE NELLA STRAVAGANZA DI QUEI SOFISTI GRECI CHE DUBITAVANO DI TUTTO E FINIVANO COL NON OSARE NEMMENO AFFERMARE IL LORO DUBBIO (Constant, probabilmente. non intende parlare dei sofisti, ma degli scettici. Affermare che occorre dubitare di tutto si riduce a dubitare che occorra affermarlo! Pretendere che non ci sia che una verità e che essa consista nell’assenza di verità, sarebbe una contraddizione).
Oltre a questa assurdità, tale dottrina è disastrosa perché sfocia inevitabilmente nell’arbitrarietà più completa. Infatti, se non ci sono princìpi, non c’è nulla di fisso: non restano che delle circostanze, e ciascuno è giudice delle circostanze. Si passerà di circostanza in circostanza, senza che le rimostranze possano trovare un punto su cui far leva. DOVE TUTTO VACILLA, NESSUN PUNTO D’APPOGGIO È POSSIBILE. IL GIUSTO, L’INGIUSTO, IL LEGITTIMO, L’ILLEGITTIMO NON ESISTERANNO PIÙ, PERCHÉ TUTTE QUESTE COSE POGGIANO SUI PRINCÌPI, E CON ESSI CADONO. RESTERANNO LE PASSIONI CHE SPINGERANNO ALL’ARBITRARIETÀ, RESTERÀ LA MALAFEDE CHE NE ABUSERÀ, LO SPIRITO DI RESISTENZA CHE CERCHERÀ DI IMPADRONIRSENE COME DI UN’ARMA PER FARSI OPPRESSORE A SUA VOLTA: IN UNA PAROLA, L’ARBITRARIETÀ, QUESTO TIRANNO TEMIBILE SIA PER QUELLI CHE SERVE, SIA PER QUELLI CHE COLPISCE, REGNERÀ SOLA.
Esaminiamo a questo punto da vicino le conseguenze dell’arbitrarietà, e, come abbiamo provato che i princìpi ben definiti e perseguiti con esattezza pongono rimedio, col loro mutuo sostegno, a tutte le difficoltà, dimostriamo, se possibile, che l’arbitrarietà, la quale non può essere né definita né seguita nelle sue conseguenze, non elimina mai, di fatto, nessuno degli inconvenienti che essa in apparenza elimina, e non abbatte nessuna delle teste dell’idra se non per farne spuntare parecchie altre.
***
L’idea dei “princìpi intermedi” di Constant e “L’idea di libertà”, 9° cap. de “La filosofia della libertà” di R. Steiner, si assomigliano in quanto riguardano sostanzialmente la stessa esigenza di individualismo etico superante il kantismo. Per Steiner non può arrivare al vero agire individuale chi manca della capacità di vivere nel singolo caso la specifica massima morale, e spiega che l’esatto contrario di questo agire individuale “è il kantiano ‘agisci in modo tale che le regole del tuo agire possano valere per tutti gli uomini’” (“L’idea di libertà”, op. cit.). Questo modo di pensare è per Steiner “la morte di ogni impulso individuale all’agire. Mi può essere di norma non il come farebbero tutti gli uomini, ma ciò che da parte mia ho da fare nel caso individuale. [...]. Gli uomini sono differenti quanto a capacità intuitiva. A uno le idee arrivano zampillando, un altro se le conquista a fatica. Le situazioni in cui vivono gli uomini, e che costituiscono la scena delle loro azioni, non sono meno diverse. Come un uomo agisca dipenderà dunque dal modo in cui la sua capacità intuitiva opera di fronte ad una data situazione. La somma delle idee operanti in noi, il contenuto reale delle nostre intuizioni, è determinato da ciò che, pur con tutta la universalità del mondo delle idee, è caratterizzato in ogni uomo in modo individuale. Questo contenuto intuitivo, in quanto rivolto all’agire, è la capacità morale dell’individuo. Il permettere la piena espressione di questa capacità è la più alta molla motrice morale e contemporaneamente il più alto motivo per chi capisce che in definitiva tutti gli altri principi morali si riuniscono in questa capacità. Questa ottica si può chiamarla INDIVIDUALISMO ETICO. [...] Chi agisce soltanto perché riconosce determinate norme morali, compie delle azioni che sono il risultato dei principi che si trovano nel suo codice morale. Egli ne è semplicemente l’esecutore. È un automa superiore. Gettate nella sua coscienza un’occasione d’agire e subito l’ingranaggio dei suoi principi morali si mette in moto e funziona secondo le regole per compiere un’azione cristiana, umanitaria, per lui disinteressata, oppure un’azione del progresso storico-culturale. Solo se seguo il mio amore per l’obiettivo, sono proprio io stesso ad agire. Quando agisco a questo gradino della moralità, non è perché riconosco un sovrano sopra di me, né l’autorità esteriore, né una cosiddetta voce interiore. Non riconosco alcun principio esterno del mio agire, perché ho trovato in me stesso la ragione dell’agire: l’amore per l’azione. Non esamino razionalmente se la mia azione sia buona o cattiva; la compio perché la AMO. Diventa “buona” se la mia intuizione d’amore è giustamente inserita nell’universale connessione intuitivamente vivibile; “cattiva” se ciò non si avvera. Non mi chiedo neanche: “Come agirebbe un altro uomo nel mio caso?”, bensì agisco così come io - questa individualità particolare - mi vedo disposto a volere. A condurmi direttamente non è il generalmente usuale, il costume generale, una massima generalmente umana, una norma morale, ma il mio amore per quell’azione. Non sento alcuna costrizione, né quella naturale che mi determina secondo i miei istinti, né quella dei comandamenti morali, ma voglio semplicemente attuare ciò che è in me” (ibid.).
Per qualsiasi tipo di obiezione a queste affermazioni rimando i difensori delle norme morali generali alla lettura integrale de “L’idea di libertà” (op. cit.). Occorre comunque saper guardare bene in noi stessi per affermare che si potrebbe allora rapinare u8na banca in n0ome dell’amore per l’azione. Così non è. “Che l’azione del delinquente, che il male siano chiamati espressione dell’individualità nello stesso senso dell’incarnarsi di un’intuizione pura, è possibile soltanto se gli impulsi ciechi sono attribuiti all’individualità umana. Ma l’impulso cieco, che spinge al delitto, non proviene dalla parte intuitiva e non appartiene alla parte individuale dell’uomo, bensì a ciò che vi è di più ordinario in lui, a ciò che è vigente in ugual misura in ogni individuo, e da cui l’uomo si libera mediante il lavoro sulla sua individualità. Ciò che è individuale in me non è il mio organismo con i suoi impulsi e sentimenti, ma l’unitario mondo delle idee che risplende in questo organismo. I miei impulsi, istinti, passioni, non fanno da fondamento a nient’altro in me se non al mio appartenere alla SPECIE GENERALE UOMO; la circostanza che in questi impulsi, passioni e sentimenti si esprima in modo particolare qualcosa di ideale, fa da fondamento alla mia INDIVIDUALITÀ. Per i miei istinti e impulsi io sono un uomo, dodici dei quali formano una dozzina; per forma speciale dell’idea mediante cui all’interno della dozzina mi qualifico come un io, io sono un individuo. Riguardo alla diversità della mia natura animale potrebbe distinguermi dagli altri solo un essere a me estraneo; mediante il mio pensare, cioè mediante l’afferrare attivo di ciò che di ideale si esprime nel mio organismo, mi distinguo io stesso dagli altri. Dell’azione del delinquente dunque non si può assolutamente dire che provenga dall’idea. Anzi, è proprio la caratteristica delle azioni delittuose il loro derivare dagli elementi extraideali dell’uomo. Un’azione è sentita come libera in quanto il suo fondamento procede dalla parte ideale del mio essere individuale; ogni altra parte di un’azione, non importa se compiuta per costrizione naturale o necessità di norma morale, è sentita come NON LIBERA [...] VIVERE nell’amore per l’agire e LASCIAR VIVERE nella comprensione per il volere altrui è la massima fondamentale degli UOMINI LIBERI” (ibid.).

Carlo Lottieri
L’Illuminismo: una verità disincarnata
- a cura di Nereo Villa -
Il rapporto tra potere e verità, menzogna e controllo sociale, si complica ancor di più con l’avvento dell’Illuminismo.
In ambito giuridico, ad esempio, è la lotta condotta in nome della “raison” contro il disordine del diritto comune che permetterà ai governanti di farsi anche legislatori, monopolizzando la produzione delle norme. Il perfezionamento amministrativo del “Polizeystaat” settecentesco e il riformismo caratteristico di questa epoca vanno incontro a esigenze ben precise della società, ma poi finiscono in larga misura per potenziare la tecnologia del potere.
In questo senso, è un certo progetto di razionalizzazione della realtà che porta l’Illuminismo ad assumere i suoi tratti più liberticidi. La cultura dei lumi non si sviluppa esclusivamente quale valorizzazione della conoscenza tecnica, quale liberalismo penale e quale superamento in senso competitivo dell’economia mercantilista. Queste sono le autentiche glorie dell’Illuminismo ed è giusto ricordarle in ogni occasione. Ma tale cultura predispone pure un ammodernamento dell’apparato statuale e una simile evoluzione rende ancora più spietato il controllo che il potere esercita sulla società (basti pensare al Panopticon benthamiano. Sul tema resta obbligatorio il riferimento a M. Foucault, “Sorvegliare e punire”, Ed. Einaudi, Torino 1993), giungendo - con un autore di primaria importanza quale Kant - a combattere perfino ogni possibilità di dissimulazione difensiva. È proprio entro questo quadro che si definisce il trionfo definitivo degli orientamenti filosofico-politici che negano esplicitamente ogni diritto di resistenza. E non deve neppure sorprendere che in un’Europa che si apre progressivamente la strada verso una “retorica della trasparenza” le istituzioni finiscano per essere sempre più pervase da trame e poteri occulti (in questo senso, il complesso intreccio del “Flauto magico” di Mozart - il libretto si deve a Emanuel Schikaneder - rappresenta forse la migliore rappresentazione simbolica di tutto ciò).
In tale fase della modernità, la dissimulazione conosce la stessa legittimazione che François de La Rochefoucauld attribuiva all’ipocrisia (“ultimo baluardo della virtù”). Le vittime vi fanno ricorso anche per legittima difesa, mentre i potenti l’utilizzano perché non è permesso loro (non ancora) di agire al fuori di ogni criterio normativo superiore. Una strategia ragionevole può consistere allora nel negare la realtà o nel sottrarsi ad essa; per questo in varie circostanze e pure in culture assai diverse “si evita che una situazione che crea problemi si produca oppure, se ciò succede, si fa finta di non vederla, ricorrendo al silenzio, alla finzione, anche alla menzogna. [ ... ] La malattia diplomatica è una delle tecniche che permettono di ritardare una scelta sgradevole, un sacrificio penoso, ma tutto questo al prezzo di una menzogna” (C. Perelman , “L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation”, Vrin, Paris 1977, p. 75). Presto questa ambiguità verrà però superata e la cosa non attesta necessariamente un progresso.
Al riguardo è fondamentale la controversia che oppose Immanuel Kant e Benjamin Constant in merito al diritto di mentire (si veda: I. Kant T, B. Constant, “La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale della politica”, a cura di Andrea Tagliapietra, Bruno Mondadori, Milano 1996). Entro tale confronto, Kant afferma che l’impossibilità di dire il falso deriva da un obbligo assoluto che investe l’Io in quanto tale: anche quando ciò dovesse comportare la morte di un innocente. Se sul piano morale la metafisica dei costumi si delinea grazie al rapporto del singolo con imperativi categorici astratti e universali, è chiaro che nessun uomo (e per nessun motivo) può sottrarsi a simili obblighi. In questo schema, però, la relazione etica cruciale connette il soggetto a se stesso, alla sua coscienza, e Kant arriva a sostenere - in parte sollecitato proprio da quella che fu una “forzatura” di Constant medesimo (Kant accetta l’esempio avanzalo da Constant e afferma che effettivamente anche nel caso-limite immaginato dall’autore dei Principes è necessario rispettare l’imperativo morale che impone di affermare sempre la verità. È possibile che Constant abbia attribuito a Kant quella tesi movendo da un passo della seconda “Critica”: “Non si è forse accorto, una volta o l’altra, qualunque uomo, anche solo mediocremente onesto, di evitare una menzogna, del resto innocua, con cui poteva o trarsi da uno spiacevole impiccio o addirittura giovare a un caro e degno amico, solo per non dover disprezzare se stesso nel segreto della sua coscienza? E un uomo per bene, nella più profonda disgrazia della vita, che avrebbe potuto evitare se soltanto fosse venuto meno al dovere, non è forse sostenuto dalla coscienza di aver tuttavia rispettato e onorato la dignità dell’umanità nella sua persona, di non doversi vergognare di fronte a se tesso, di non dover tenere lo sguardo interiore di un esame di coscienza? Questa consolazione non è la felicità. Non è neppure la minima parte di essa, perché nessuno si augurerebbe l’occasione di provarla; e, forse, neppure di vivere in tali contingenze. Ma egli vive, e non può tollerare di essere, ai suoi propri occhi, indegno della vita”; I. Kant, “Critica della ragion pratica”, a cura di Vittorio Mathieu, Ed. Rusconi, Milano 1993, p. 189) - che la protezione della propria purezza possa comportare perfino il sacrificio di un uomo ingiustamente braccato dal potere.
La visione kantiana è intellettualistica in due sensi: perché ritiene che l’obbligo di dire la verità sia un principio generale (di fronte al quale un uomo retto non deflette mai), e poi perché la regola di non mentire in nessuna circostanza è riconosciuta assoluta sulla base del fatto che non si può universalizzare la pretesa di non dire il vero (nel “De mendacio” Agostino sembra abbracciare una prospettiva non lontana da quella kantiana, opponendosi - anche grazie a un’ermeneutica dei testi acri - a ogni ipotesi che legittimi la menzogna. Ma in realtà il quadro è completamente diverso dato che il Padre della Chiesa discute l’alternativa tra verità e falsità non in astratto, ma essenzialmente in rapporto alle questioni di fede e quindi chiedendosi se un cristiano può rinunciare ad annunciare la verità del Vangelo se ciò può essere strumentale alla stessa conversione di altri uomini. La conclusione, per giunta, è ben lontana dal rigorismo di Kant: “Quanto alla menzogna dunque, o la si evita comportandosi rettamente, o la si confessa e ci si pente. Né deve succedere che la si faccia proliferare rendendo miserabile la nostra vita e, tanto meno, che la si moltiplichi insegnandola ad altri. Se qualcuno ritiene lecito mentire quando si tratta di soccorrere il prossimo in pericolo per la salute tanto fisica che spirituale, scelga pure qualsiasi tipo di menzogna; ma che almeno anche costoro ci concedano che per nessun motivo si può giungere fino allo spergiuro e alla bestemmia” (Agostino, “De mendacio”, XXI, 41, i corsivi sono miei).
Qui la vita etica è intesa essenzialmente quale adesione a principi di carattere generale: e in tal senso non sorprende che Kant abbia avuto un ruolo cruciale nella costruzione del “Rechtsstaat” continentale, caratterizzato dall’identificazione tra diritto e universalismo delle regole (a tale riguardo, le critiche indirizzate da Leoni alle tesi di Hayek esposte in “The Constitution of Liberty” - e in scritti precedenti poi rifusi in quel volume - rappresentano una critica radicale - anche senza volerlo - della matrice latamente kantiana di quella formulazione teorica. Si veda ad e empio: B. Leoni, “Testo stenografico dell’intervento”, 4 settembre 1957, Mont Pélerin Socìety, meeting di St. Moritz, in “Il Politico”, n. 3, 1957, pp. 708-709). Lo stesso nucleo morale della pratica pietista che si può riconoscere sullo sfondo di tale riflessione è più un criterio astratto e un fondamento necessario - la “Grundnorm” etica in condizione di sorreggere l’intero sistema - che non il riconoscimento di persone incontrate e divenute parte della propria esperienza. In qualche modo, l’etica occidentale sconta qui tutte le conseguenze derivanti dall’aver adottato all’interno della filosofia pratica il concetto stesso di legge, sorto dapprima in ambito giuridico e poi applicato analogicamente nei trattati sulla morale.
Per l’illuminista Kant al centro delle preoccupazioni vi è quella pubblicità (che è “Publizität”, ossia “trasparenza”, ma al tempo stesso “Öffentlichkeit”, da intendersi quale “spazio pubblico”, condizione stessa dell’accessibilità del diritto che trova forma compiuta nel sistema giuridico, da lui sempre inteso come l’ordine statuale in grado di trascendere le singole individualità (commentando un testo di Alexandre Koyré sulla menzogna politica Derrida ricorda, contro ogni pretesa semplificatrice, che “l’opposizione veracità/menzogna è omogenea a una problematica testimoniale, e niente affatto a una problematica epistemica del vero-falso e della prova”. Qui non si tratta di negare ogni verità, bensì di muoversi in maniera non ingenua. Ma oltre a questo il filosofo francese si chiede giustamente se l’ossessione moderna per la trasparenza “non annunci […] un’egemonia assoluta della ragion politica, di un’estensione senza limite della sfera del politico”; J. Derrida, “Breve storia della menzogna. Prolegomeni”, Ed. Castelvecchi, Roma 2006, p. 80 e p. 85). Nello scritto intitolato “Per la pace perpetua” egli individua nel seguente principio la formula trascendentale del diritto pubblico: “Tutte le azioni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non è suscettibile di pubblicità [Publizität], sono ingiuste” (I. Kant, “Per la pace perpetua”, 1795, Appendice II: “Dell’accordo della politica con la morale secondo il concetto trascendentale del diritto pubblico” in “Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto” UTET, Torino 1995, p. 328).
Qui non è però la trasparenza del potere che sta a cuore, ma quella della società. E di conseguenza non ci si può sorprendere se entro la prospettiva del pensatore tedesco viene meno ogni diritto di resistenza - difeso invece da una lunga tradizione, dalla Seconda Scolastica a John Locke - dato che “l’ingiustizia della ribellione si rende chiara da questo: che la massima di essa, qualora fosse pubblicamente conosciuta, renderebbe impossibile il suo proprio scopo” (ibid., p. 331. Nella “Metafisica dei costumi” Kant afferma che “contro il supremo legislatore dello Stato non vi può dunque essere nessuna resistenza legittima da parte del popolo, perché soltanto grazie alla sottomissione di tutti alla sua volontà universalmente legislatrice è possibile uno stato giuridico”; I. Kant, “La metafisica dci costumi”, I, parte II, sezione I, nota A [Nota generale sugli effetti giuridici derivanti dalla natura della società civile], Ed. Laterza, Roma-Bari 1989, p. 150). Kant ritiene contraddittoria la creazione, da parte del popolo, di un potere irresistibile (che ai suoi occhi è la condizione necessaria della pace e del diritto) a cui poi qualcuno pretendesse di “opporsi” e di fronte al quale ci si potesse ribellare (in questo senso, Kant non offre alcuna possibilità di contrasto di fronte all’imporsi di una prospettiva giuspositivistica, poiché l’esito conseguente delle assunzioni che sono alla base della teoria del “Rechtsstaat” è nell’identificazione di legalità e giustizia. Come scrive Passerin d’Entrèves, «separato nettamente il “diritto come fatto” e il “diritto come valore”, eliminato dalla considerazione del diritto ogni riferimento valutativo o contenutistico, condizione unica ed esclusiva per l’esistenza di un ordinamento giuridico diventa la sua “efficacia’; cioè la sua esistenza di fatto, ed ogni Stato, in quanto ordinamento giuridico, è, per definizione, uno “Stato di diritto”» (A. Passerin D’Entrèves, “La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione”, Ed. Giappichelli, Torino 1962, p. 208).
Tale esito liberticida è comunque correlato al fatto che la stessa esperienza etica è ridotta a “puro dovere”: adesione a una norma (Gesetz) che confina la vita morale nel più rigido legalismo (diversa è la posizione di Rousseau nella quarta “promenade” delle sue “Réveries du promeneur solitaire”, dove afferma che sostenere che si debba sempre essere veraci significa “chiudere la questione senza averla risolta”. Il guaio è che il ginevrino sposa una sorta di spontaneismo emotivo: “non ho mai agito secondo una regola, o non ho mai seguito altra regola che gli impulsi della mia indole [naturel]” (J.-J. Rousseau, “Réveries du promeneur solitaire”, Slatkin, Genève 1995, p. 109 e p. 121). L’atto del mentire rappresenta “la maggiore infrazione del dovere dell’uomo verso se stesso” (I. Kant, “La metafisica dei costumi”, II, libro I, parte I, § 9, p. 287. In merito a tutto questo è interessante quanto Lévinas scrive nel 1990 per “Critical Inquiry” nel breve testo volto a introdurre la ripubblicazione di “Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme”, del 1934. Lévinas rievoca la rilettura del liberalismo sviluppata in quelle pagine, riferendosi a quel “soggetto dell’idealismo trascendentale che innanzitutto si vuole e si crede libero”, aggiungendo che “dobbiamo chiederci se il liberalismo possa bastare alla dignità autentica del soggetto umano. Il soggetto raggiunge la condizione umana prima di assumere la responsabilità per l’altro uomo nell’elezione che lo eleva a questo grado?”; E. Lévinas, “Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo”, Ed. Quodlibet, Macerata 1996, pp. 21-22). Ma a questo punto l’enfasi sull’intenzione svuota d’interesse la concretezza dell’atto, il suo incontrare la realtà: l’altro uomo è dissolto, poiché la vita morale del singolo basta a sé, al punto da degradare il prossimo a mera “occasione” di una propria perfezione interìore? (sebbene lontano da ogni Romanticismo, qui Kant porta alla mente talune analisi di Denis de Rougemont sull’evoluzione dell’amore nella civiltà occidentale. Nel suo saggio, de Rougemont ha acutamente rilevato come nel “romance” - e fin dalle origini - quell’“altro da sé” che è occasione di infatuazione e innamoramento spesso non ha tratti definiti, poiché è semplicemente funzionale all’“amour passion” che domina il soggetto. Nel medesimo testo, così, Isotta può essere descritta quale bionda o mora, perché in realtà non ha una presenza propria, ma la sua realtà è meramente funzionale all’estasi - di fatto solitaria - di un Tristano che è attratto dall’innamoramento stesso più che dalla donna in carne ed ossa che è dinanzi a lui. Si veda: D. De Rougemont, “L’amore e l’Occidente”, Ed. Rizzoli, Milano 1977). L’eclissi del “Lebenswelt” annulla ogni esigenza di equità, così che il caso particolare smarrisce la sua peculiarità e il soggetto della stagione kantiana è incapace di usare la necessaria umanità che talune circostanze possono esigere (Tagliapietra evidenzia come in Kant venga meno “la pietà dell’eccezione”; A. Tagliapietra, “Il diritto alla menzogna. Kant, Constant, politica della verità e politiche dell’amicizia”, introduzione a I. Knt - B. Constant, “La verità e la menzogna”, op. cit., p. 27).
Nella filosofia kantiana la veridicità assoluta è al servizio dell’Io e della sua perfezione, ma è pure premessa alla possibilità di una collettività in grado di rappresentarsi trasparente. A giudizio di Charles Taylor, con Rousseau e poi con Herder s’afferma l’idea che “ciascuno di noi ha una sua maniera originale di essere uomo” (C. Taylor, “Il disagio della modernità”, E. Laterza, Roma-Bari 1994, p. 35): è il mito moderno dell’autenticità. Ma quando questo diventa il proprio ideale, in qualche modo l’essere finisce per coincidere con il dover essere, e soprattutto viene meno l’idea stessa che la relazione interpersonale sia l’orizzonte della vita morale.
All’interno di una riflessione di ordine filosofico-politico, è importante cogliere come l’Io individuale di un’etica basata dovere introduce al grande Io di una “Gemeinschaft” che si esprime e concretizza nella “volonté générale” (la continuità con Rousseau appare evidente a più livelli, anche se - a giudizio di Gierke - Kant “continuò a identificare lo Stato con la somma degli individui associati, e la volontà generale sovrana col volere concorde e unitario di tutti”, dato che “egli sostituì completamente alla sovranità di un soggetto vivente quella della astratta legge della ragione” (O.Von Gierke, “Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle dottrine politiche giusnaturalistiche”, Einaudi, Torino 1943, pp. 158-159). L’esigenza .di una veridicità assoluta difesa dal filosofo tedesco è quindi eminentemente politica, dato che l’esistenza di un’autentica comunità è condizione perché vi sia vita sociale, e il mentitore abolisce la società” (I. Kant, “Sui doveri etici verso gli altri. La veridicità”, 1775-81, in I. Kant – B. Constant, “La verità e la menzogna”, op. cit., p. 235). Sullo fondo è facile riconoscere le esigenze di chi sta edificando il “Rechtsstaat” e persegue quindi una certa idea di diritto e giustizia (a questo proposito va ricordata la tesi di chi, come Gottfried Dietze, ha affermato che “la strada fra lo Stato di diritto di Mohl e lo Stato di potenza (“Machtstaat”) di Hitler è una strada lunga”, ma essa “è molto meno tortuosa di quanto si immagini”; e questo proprio in ragione del fatto che “a causa della sua progressiva formalizzazione, lo Stato di diritto era alla mercé della migliore e della peggiore legislazione, del migliore o del peggiore diritto positivo”; G. Dietze, “Lo Stato di diritto nel diritto naturale e nel diritto positivo”, in S. Noto, a cura di, “Alessandro Passerin d’Entrèves pensatore europeo”, Ed. il Mulino, Bologna 2004, p. 222 e p. 224).
La discussione sul reale o presunto “kantisrno” di Adolf Eichmann, che nel processo tenutosi a Gerusalemme “dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principi dell’etica kantiana, e in particolare conformemente a una definizione kantiana del dovere” (H. Arendt, “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”, Ed. Feltrinelli, Milano 1999, pp. 142-143), può qui offrire qualche spunto illuminante. Hannah Arendt ha ragione quanto evidenzia come nel protagonista della Endlösung (la soluzione finale) vi sia un’inconsapevole distorsione della morale kantiana; per giunta, sarebbe assai poco caritatevole, oltre che anacronistico, immaginare che la “Critica della ragion pratica” sia da porsi in diretta connessione con il nazismo. Ma è pur vero che, in Kant, il formalismo dell’etica e il legalismo della filosofia politica hanno reso possibile questa controversia. La morale si fa semplice dovere dinanzi a una norma e tale obbligatorietà si ripresenta con caratteri assai simili nella negazione di ogni diritto a rivoltarsi” (sulla questione si vedano: N. Ranasinghe, “Ethics for the Little Man: Kant, Eichmann, and the Banality of Evil”, in “The Journal of Value Inquiry”, 36, n. 2-3, giugno 2002, pp. 299-317; C. B. Laustsen, R. Ugilt, “Eichmann’s Kant”, in “The Journal of Speculative Philosophy”, vol. 21, n. 3, 2007, pp. 166-180.).
Quando la Arendt tratteggia Eichmann come un uomo terribilmente normale (“Il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n’erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali” (H. Arendt, “La banalità del male”, op. cit., p. 282), la banalità assume due caratteri fondamentali, che possono in qualche modo essere ricondotti a Hobbes e Kant.
In primo luogo egli sposa il male in ragione della sua ossessiva volontà di “realizzarsi”: conseguendo il successo. Il “self-interest” non va demonizzato, ma qui esso si colloca entro un quadro hobbesiano che nega ogni dignità agli altri e celebra il trionfo di un’antropologia integralmente materialistica e autocentrata, che è tanto più dominata dall’aggressività quanto più è tenuta in scacco dalla paura (per questa interpretazione del rapporto tra il totalitarismo e un “self-interest” assolutizzato e senza limiti, si leggano le pagine consacrate a Hobbes: H. Arendt, “Le origini del totalitarismo”, Edizioni di Comunità, Milano 1967, pp. 193-204).
Questo individualismo ha tratti assai particolari. Come si è già sottolineato lo stato di natura che in Hobbes precede l’instaurarsi dell’ordine statale è contraddistinto dall’assenza del diritto e, più precisamente, del diritto di proprietà (nella sua riflessione sull’individualismo di Eichmann, Shiraz Dossa ne coglie il carattere hobbesiano, riconoscendo pure come l’individualismo di Locke sia di tutt’altra natura. Il giudizio è corretto, ma le ragioni che offre sono ben lungi dall’essere convincenti. Il “liberale lockiano” è strutturalmente diverso dall’individuo hobbesiano e eichmanniano non già perché “secondo Locke la dimensione pubblica e il bene pubblico sono elementi degni e necessari all’interno dei calcoli dell’uomo liberale”; S. Dossa, “Hannah Arendt on Eichmann: The Public, the Private and Evil”, in “The Review of Politics”, vol. 46, n. 2, aprile 1984, p. 170;, ma semmai perché l’antropologia cristiana e giusnaturalista dell’autore dei “Treaties” lo costringe a prendere costantemente in considerazione l’esistenza degli altri: che sono individui da rispettare e con cui è possibile interagire e cooperare). Ma negare la proprietà significa abolire l’alterità stessa (la Arendt evidenzia come il totalitarismo faccia venir meno ogni spazio privato - e dunque la stessa privacy - ed egualmente sottolinea che la violenza di un piccolo uomo quale Eichmann sia stata motivata da ambizioni illimitate che finirono per assolutizzare la privacy medesima entro un quadro, però, in cui alterità e proprietà erano state totalmente abolite; e questo perché egli mostrò sempre “eccezionale diligenza nel pensare alla propria carriera” (H. Arendt, “La banalità del male, op. cit., p. 290).
Il secondo elemento, cruciale per comprendere il funzionario dello sterminio va individuato nel fatto che in Eichmann si ha il venir meno di ogni responsabilità e ciò è dovuto al trionfo di decisioni di carattere impersonale: la coscienza è assorbita da logiche funzionali, così che a un certo punto non “agisce”, ma semplicemente “esegue”. In qualche modo egli abdica alla sua umanità in quanto è solo un burocrate e nient’altro. Tale dissolversi della moralità nella mera adesione alle regole è però incomprensibile al di fuori di una storia istituzionale che ha il proprio compimento nel “Rechtsstaat”. In questo senso, la logica eticizzata di uno Stato di diritto che è essenzialmente “forma” - e che ancor più lo diverrà nel suo sviluppo positivistico - è ciò che in qualche modo connette la speculazione kantiana agli esiti drammatici della storia tedesca del Novecento (bisogna ricordare, come sottolineò Del Noce, come “si possa benissimo stabilire di fatto una tirannide, nel rispetto formale dello Stato di diritto» (A. Del Noce, “Il problema dell’ateismo”,Ed. il Mulino, Bologna 1964, p. 307 e n. 8).
Quando Eichmann ricorda che per due volte non rispettò il sacro dovere kantiano di obbedire al diritto (nel momento in cui aiutò un parente di origini ebraiche e anche una famiglia segnalatagli da uno zio), subito però aggiunge di aver poi «“confessato le sue colpe” ai superiori»!” (H. Arendt, “La banalità del male”, op. cit., p. 144). Nonostante l’umana debolezza, alla fine il senso del dovere aveva prevalso. Se il peccato consisteva nell’aver anteposto l’esperienza di un incontro alla logica di una regola astratta, questo significa che la criminalità banale dello sterminio era nella sua essenza l’espressione di un legalismo che identificava legittimità e legalità [la sottolineatura in grassetto è mia - ndc], ma che soprattutto attribuiva a quest’ultima l’aura di un “dover essere” a cui non ci si doveva sottrarre.
Al rigorismo di Kant e alle derive giacobine di un diritto totalmente disincarnato è allora opportuno contrapporre l’umanità (seppure non priva di tratti incoerenti) di Constant, che nel rigettare le tesi del filosofo tedesco pone al centro della scena l’esigenza di contemperare ragioni e principi diversi. Questa maggiore attenzione al singolo e alla sua complessità proviene da una differente concezione filosofico-politica. Mentre Kant trasferisce la sovranità assoluta dello Stato moderno dalla persona del monarca all’impersonalità delle leggi (è interessante ricordare che Kant ritenga legittima la pena di morte, contro la tesi di Cesare Beccaria, secondo cui l’individuo non può - entrando in società - consegnare al potere il controllo sulla propria vita, che è un bene indisponibile. È sicuramente vero che in Kant la pena capitale discende da una concezione retributiva, in ragione della quale l’assassino deve essere giustiziato “affinché ciascuno porti la pena della sua condotta”; I. Kant, “La metafisica dei costumi”, op. cit.; ma questo passaggio non sarebbe stato possibile se per il filosofo tedesco il legislatore non fosse la collettività stessa e se ciò non permettesse il trasferimento del diritto alla vita dal singolo allo Stato. La questione è cruciale perché conferma come la “politica” kantiana sia un universo giacobino: non una società libera fatta di convenzioni stipulate da individui titolari di diritti naturali, ma invece una costruzione razionale che prescinde dal consenso dei singoli e non rinvia più al proprietario lockiano, ormai del tutto privato del suo “fortilizio” originario), in Constant vi è una decisa critica del potere politico in quanto tale, insieme al progetto di una sua limitazione (ecco come Constant si esprime in merito al potere illimitato: “Gli uomini e le classi, investiti da poteri senza limiti s’inebriano di questi poteri. Non bisogna mai supporre che, in alcuna circostanza, una potenza illimitata possa essere ammissibìle, e, nella realtà, essa non è mai necessaria”; B. Constant, “Sugli effetti del Terrore”, in I. Kant - B. Constant, “La verità e la menzogna”, cit., p. 139).
L’autore svizzero non rinuncia all’idea che vi siano principi, ma distingue tra principi primi e intermedi, sottolineando come sia “fuor di dubbio che i principi astratti della morale, se fossero separati dai loro principi intermedi, produrrebbero tanto disordine nelle relazioni sociali degli uomini quanto i principi astratti della politica, separati dai loro principi intermedi, devono produrne nelle relazioni civili”. Egualmente, “quando si dice che i principi generali sono inapplicabili alle circostanze, si dice semplicemente che non si è coperto il principio intermedio richiesto dalla combinazione particolare di cui si occupa” (B. Constant, “Sulle reazioni politiche”, in I. Kant – B. Constant, “La verità e la menzogna”, op. cit., p. 209 e p. 204).
In Constant la distinzione tra principi primi e intermedi intende salvare - contro le tesi di Edmund Burke e i suoi possibili esiti relativisti - l’idea che esistano principi di carattere generale, e al tempo stesso intende però contestare - contro le tesi di Kant e i suoi inevitabili esiti assolutisti - l’idea che essi possano bastare a dirci come dobbiamo agire. In tal modo, l’autore dei “Principes de politique” prende a cuore soprattutto il rapporto delle norme con le situazioni: con l’altro e con la realtà effettiva della persona che incontriamo lungo la nostra strada (in “Sleepers” di Barry Levinson, un fìlm del 1995 tratto da un romanzo di Lorenzo Carcaterra, una figura moralmente esemplare è padre Bobby, un sacerdote che testimonia il falso in tribunale - dopo aver giurato sulla Bibbia - allo scopo di salvare due ragazzi, ormai divenuti killer e tossicodipendenti, che a molti anni di distanza dalle violenze subite hanno ucciso un sorvegliante della prigione che ha aveva imposto loro ogni genere di sofferenza).
C’è qui l’anticipazione di temi che saranno cruciali nella riflessione di Emmanuel Lévinas, per il quale l’esperienza dell’altro è da anteporre a ogni universalismo astratto: “in Kant è l’universalità della massima che determina l’imperativo categorico; per me è altri come persona che determina l’imperativo categorico. In questo secondo caso l’universalità, anziché precedere, verrebbe dedotta” (E. Lévinas, P. Ricoeur, “Giustizia, amore e responsabilità. Un dialogo tra Emmanuel Lévinas e Paul Ricoeur, in E. Lévinas, G. Marcel, P. Ricoeur, “Il pensiero dell’altro”, Edizioni Lavoro, Roma 1999, p. 79). Entro questa prospettiva è ingiustificabile il comportamento di chi pretende di salvare la propria integrità morale (la propria astratta perfezione) anche a costo di immolare la vita di un suo simile bisognoso di protezione (un autore liberale che non assolutizza il dovere di dire la verità è Antonio Rosmini, che antepone la libertà giuridica del singolo a ogni astratto dovere di non mentire o essere sempre veridici. Ecco cosa scrive in merito: “un uomo per sé non ha diritto di pretendere da un altro che gli comunichi le cognizioni da lui possedute: questa comunicazione appartiene alla beneficenza, e non al dovere giuridico. Laonde se un uomo risponde ad un altro: “io non voglio dirvi nulla di ciò che volete sapere”, egli non esce con ciò dal giusto, considerato giuridicamente; rimansi entro la sfera del suo, e non invade l’altrui”; A. Rosmini, “Filosofia del diritto”, vol. I, Ed. Cedam, Padova 1967, p. 202).
Constant punta a evitare l’esito a cui pervengono quanti non vogliono saperne di principi perché intendono sposare una prospettiva integralmente utilitarista, ma al tempo stesso si propone di proteggere la complessità del reale. Si intende così scongiurare egualmente il dispotismo dei “partigiani dell’arbitrio”, senza per questo illudersi che si possa derivare ogni corretto comportamento da criteri generali e astratti (ibid. p. 215). Quanto questo avesse evidenti intenzioni politiche è messo in risalto da Andrea Tagliapietra quando sottolinea che “mentre Kant mira soltanto a sostituire la fonte del potere sovrano, spostando l’assolutismo personale del monarca in direzione della formale impersonalità della legge, ma conservandone integralmente le caratteristiche coercitive e totalitarie - ossia di “vincolo incondizionato” - Constant mette in discussione la qualità stessa del potere, la forma che esso può assumere nell’ambito complesso della modernità” (A. Tagliapietra, “Il diritto alla menzogna. Kant, Constant, polica della verità e politiche dell’amicizia”, op. cit., p. 57).
Grazie all’artificio dei principi intermedi Constant sottrae la morale al rigorismo doverista: la valorizzazione dell’alterità si accompagna alla riscoperta dell’eccezione e di quella molteplicità che il legalismo di tradizione continentale ha preteso di cancellare (il fossato che separa il progetto di autoperfezione delineato da Kant e il senso vivido della realtà espresso da Constant delinea uno spazio problematico grazie al quale è possibile trovare anche un’utile chiave di lettura di talune tensioni interne al liberalismo classico e ai suoi sviluppi libertari, opponendo a un liberalismo caratterizzato dal riconoscimento originario dell’alterità un altro liberalismo, tutto centrato sull’Io e anche predisposto - in speciali circostanze - ad esaltare un Io collettivo e misticamente inteso).